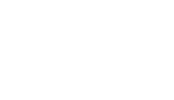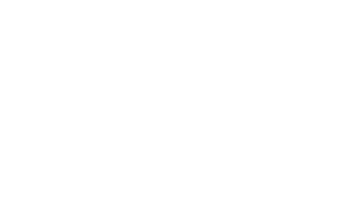Le prime pitture ad affresco nella ‘Maestà’ lungo la strada per Arezzo, a valle di Laterina, risalgono alla seconda metà del Trecento come ci testimonia la data “25 mensis Augusti 1372”, incisa da un ignoto pellegrino sulla decorazione geometrica perimetrale. Qui, secondo la tradizione, avrebbe predicato San Bernardino (1380-1444), particolarmente devoto alla Vergine; il santo proveniva da Siena, verosimilmente, dopo aver percorso la Valdambra e attraversato l’Arno al Ponte Romito.
È dopo la sua morte, avvenuta il 24 maggio 1444, e forse, negli anni immediatamente posteriori alla sua canonizzazione, risalente al 1450, che il “sacellum” fu riaffrescato, su committenza della popolazione di Laterina o della locale Compagnia laicale dedicata a Maria. Che il luogo, allora disabitato e ai margini delle paludi, fosse in quegli anni oggetto di culto e di pellegrinaggi ci è testimoniato da altre iscrizioni: quella di un certo Marco, risalente proprio al 1450, e l’altra del chierico aretino Giovan Battista Ricci, qui lasciata “ad perpetuam memoriam” del suo passaggio nel 1451 ( A perpetua memoria, in questa cappella si riposò, assai stanco nelle gambe per il viaggio, Giovan Battista Ricci [… ], chierico aretino, stravolto nella mente, e da questi luoghi solitari si trasferì ad Arezzo 1’8 luglio 1451″ ).
Nella parete di fondo venne dipinta la Madonna della misericordia tra i Santi Antonio e Bernardino. Nella parete di sinistra fu raffigurata la Crocifissione e in lontananza (ma fuori dal quadro) il castello di Laterina; nell’imbotte Dio Padre benedicente e lo Spirito Santo.
La Madonna, il cui voIto è quasi illeggibile, tiene aperto l’ampio mantello rosso, internamente foderato di azzurro, che accoglie maternamente i devoti (a destra le donne e a sinistra gli uomini). Le figure sia maschili che femminili hanno tratti assai delicati, con trasparenza e luminosità degli incarnati che ricordano la luce ed il colore del senese Sassetta (fine secolo XIV-1450), di un Giovanni di Paolo (1389- 1482) o di Pietro di Giovanni d’Ambrogio (1409 ca-1449);
il bianco del velo che copre la testa delle donne più anziane spicca sul fondo del manto della Vergine, come le elaborate acconciature a treccia avvolta intorno alla nuca di una raffinata dama o i biondi capelli sciolti di una fanciulla in primo piano. Dietro alla Madonna, due angeli reggono un drappo in un atteggiamento già presente in altre simili raffigurazioni aretine, ma di sapore più arcaico, quali l’affresco staccato di Giovanni d’ Agnolo di Balduccio (m. 1452) del Monastero di Santa Maria Novella ad Arezzo, ora nel locale Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna. Rispetto alla Madonna della Misericordia dipinta da Parri Spinelli (1387-1453) nell’oratorio aretino voluto da San Bernardino da Siena nel 1428 (Santa Maria delle Grazie), l’affresco di Laterina abbandona ogni reminiscenza della tradizione tardo gotica in favore di una iconologia rinascimentale espressa dai più moderni pittori senesi, cui va ricollegata, piuttosto che, come è stato scritto, alla bottega fiorentina di Neri di Bicci (1419-1492).
Il Crocifisso forse è da ascrivere alla stessa mano della raffigurazione precedente.
Agli anni 1480-90, è invece ascrivibile la Madonna in trono con il Bambino, opera di un artista forse aretino, ma di formazione fiorentina. L’affresco è quasi del tutto perduto in corrispondenza della figura della Vergine, è, invece, abbastanza leggibile il Bambino. Il trono, in prospettiva centrale, è impreziosito lateralmente da motivi classici a candelabre, mentre, sul suo retro, vi è una decorazione monocroma a racemi e soli bernardiniani; la scena è inquadrata all’interno di due pilastri dorici sorreggenti un arcone a tutto sesto, tipici delle nuove architetture dell’Umanesimo “antiquario”, ma qui resi in maniera alquanto rigida e popolare, con un uso incerto e talvolta sgrammaticato della prospettiva architettonica.
Sempre al Quattrocento dobbiamo l’ampliamento della cappella mediante l’oratorio posto alla sua sinistra. In quest’ultimo venne affrescata, intorno al 1480- 1485, una Madonna in trono con il Bambino, l’opera più interessante dal punto di vista storico artistico.
Entro una nicchia è raffigurata, sulla parete di fondo, la Vergine con il Bambino in grembo, seduta su uno scanno (quasi del tutto perduto nella parte interiore, a foggia di absidiola catinata a valva di conchiglia verde e con pilastrini laterali sui quali si imposta la cornice dorata, raffigurata prospetticamente. La Madonna, fortemente ridipinta nell’Ottocento, dopo i difficili restauri (eseguiti dalla ditta S.A.R. di Firenze sotto la direzione di Laura Speranza) che hanno ridato leggibilità all’affresco tardo quattrocentesco, presenta un mantello azzurro foderato di verde che scende dalla testa ed è fermato sul petto da un bottone dorato; la fronte è ricoperta da un trasparente velo bianco. La veste, color rosso rubino, è fermata sotto il petto con una fascia rosacea stretta da un nodo. Lo sguardo di Maria è rivolto verso il Bambino, in piedi sulle ginocchia della madre: paffuto con i riccioli biondi, di una corporeità quasi masaccesca, stringe con la manina un rondinotto.
L’affresco, recentemente dato ad ambito lippesco, ancor più che con la maniera di Filippo Lippi (1406 ca-1469) o di alcuni suoi stretti collaboratori e seguaci, come fra’ Diamante (1430-post 1498) – maniera caratterizzata da un ductus più gentile e delicato – ha alcune suggestive assonanze con la pittura del Verrocchio (si veda la bella mano sinistra, affusolata e nervosa, della Vergine oppure il caratteristico nodo della cintura legata sotto il suo petto). Tuttavia, numerosi e indubbi sono anche i richiami all’opera pierfrancescana, quali la monumentalità regale della figura e lo sguardo assorto della Vergine. Se, come è stato detto da Paolucci, “il radicamento dell’arte di Piero della Francesca nella Toscana interna [… ] municipale, feudale e contadina” si manifesta attraverso autori come Lorentino d’Andrea, proprio nell’ambito di questo artista minore va ricercato l’autore del nostro affresco. Lorentino d’Andrea, detto anche Lorentino d’Arezzo (1430 – 1506), è un pittore che ha lavorato insieme Piero della Francesca (1417-1492) nella chiesa aretina di San Francesco e che ne traduce e divulga l’arte con un tono più popolare e devoto, meno aristocratico e astratto.
Licia Bertani