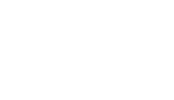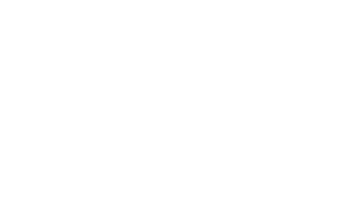La tavola, originariamente conservata in Santa Maria in Valle, raffigura la Madonna in trono col Bambino (cm 113×41); ha l’aureola sagomata e leggermente sporgente. La tela, secondo la consuetudine messa in corrispondenza al legno, mantiene solo frammentarie tracce di colore. Lo stato di conservazione, infatti, è assai mediocre, poiché la parte inferiore è quasi del tutto scomparsa, così come il volto del Bambino, di cui si leggono solo gli occhi, il naso e il labbro superiore, mentre l’ovale del volto e l’aureola, forse non dorata ma a foglia d’argento, sono del tutto cancellati. Si notano anche delle bruciature nella parte destra, dovute alle candele, che venivano accese di fronte alla sacra immagine. La Vergine indossa un manto azzurro foderato di rosso che le copre la testa e scende sulle spalle con ricche pieghe un po’ rigide, ma, tuttavia, già di sapore gotico per la scioltezza del tracciato. L’abito del Bambino doveva essere marrone con lumeggiature bianche, come si può intravedere dai frammenti di colore superstite. L’opera è riferibile all’ambito di Margarito d’Arezzo (noto dal 1250 al 1262) e databile intorno agli anni 1260-1262, assai vicina alla Madonna in trono col Bambino e Santi, conservata nel Museo Statale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo e proveniente da Terranova Bracciolini.
L’ aspetto provinciale dell’immagine può sembrare un’imitazione vernacolare dell’arte bizantineggiante, tuttavia, conserva una sua genuinità e freschezza che la colloca fra le opere di indubbio interesse. Secondo la tradizione, in epoca imprecisata, la tavola sarebbe stata rinvenuta sotto terra da alcuni contadini e collocata in varie chiese, tra cui quella del Castello di Montozzi (Pergine), ma ogni volta sarebbe stata ritrovata nel luogo originario. Il miracoloso evento avrebbe dato inizio alla grande devozione popolare verso la sacra icona e all’edificazione di un santuario in quel luogo. Tale leggenda non ha fondamento storico poiché la chiesa di Santa Maria in Valle esisteva già nel XIII secolo. Il sito, per la sua posizione, doveva essere sacro fin dall’antichità e la Madonna assumeva in sé varie identità di divinità legate alla terra, come Cerere, dea delle messi, e alle acque, come le ninfe delle sorgenti ed altre creature femminili soprannaturali. Queste sacre presenze sottolineavano simbolicamente il potere fertilizzante dispensato dalle divinità ctonie (sotterranee) sotto forma di acque di ‘profondità’ sgorganti da sottoterra, al pari della Madonna, come vuole la leggenda, emersa dalla terra. Del resto, le popolazioni rurali, per tutto il Duecento, avevano bisogno di affidarsi alla protezione di Maria per sfuggire alle scorrerie degli eserciti fiorentino ed aretino.
Nel 1974 una parte della tavola fu rubata: la testa della Madonna fu separata dal resto e trafugata. Ritrovata quasi subito, dopo il restauro, venne portata in luogo più sicuro; si conserva infatti, gelosamente, nella propositura di Laterina.
Sulla cantoria del santuario è posto il piccolo organo positivo (strumento di medie proporzioni che si può trasportare da un luogo all’altro ma che deve essere collocato su un mobile), di Anonimo, risalente al secolo XVII, ma con canne più antiche e con aggiunte del 1714, come si può leggere nella secreta che recava anche il nome dell’autore, ora perduto. Probabilmente fatto costruire durante la campagna di lavori promossa dalla famiglia Busatti, lo strumento ha una tastiera di 45 tasti (Do1 – Do5) con la prima ottava corta. La pedaliera ha 8 pedali (Do1 – Si1); i registri sono quattro: Principale (4′), Ottava, Duodecima e Decima-quinta; il somiere è a tiro. La cassa, riferibile al Primo Settecento, presenta due lesene laterali d’ordine tuscanico ed un lineare cornicione, sormontato da una cimasa in legno scolpito a tralci di vite e grappoli d’uva, con al centro uno stemma vescovile.
Licia Bertani