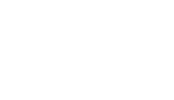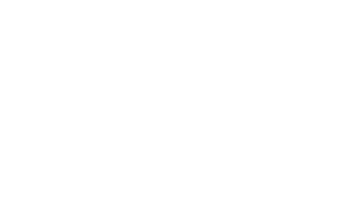Il borgo si sviluppò planimetricamente a ‘sigaro’ in cui presenta una dilatazione da est verso ovest dove costruirono due porte principali (quella Fiorentina ad Occidente e, verosimilmente, l’Aretina in corrispondenza del cassero o rocca ubicata presso l’estremità orientale, nel luogo maggiormente elevato).
Non sappiamo se fin da allora esistessero altre due porte secondarie in quanto con la ricostruzione fiorentina della prima metà del Trecento, Laterina ha le mura restaurate con tre (o forse quattro) porte munite di torre, esemplate su quelle arnolfiane di Firenze.
Ad oggi sono rimaste: a sud quella della Pieve, che in seguito verrà detta anche di Valle, verso l’antica pieve di Campavena, e a nord la Porta Fredda o di Ghianderino, in direzione del ‘popolo’ di San Lorenzo in Glandarino verso il Pratomagno, una delle comunità inurbatosi a Laterina sin dall’XI secolo. La trecentesca Porta Fredda, originariamente detta di Ghianderino e nei secoli seguenti anche Porta Colonna, dell’Oreno, o Montanara, costituisce un bell’esempio di ‘postierla’ medievale, cioè una porta urbana minore. Immediatamente al di là del fornice e delle carbonaie (non più esistenti) iniziava la ripida discesa verso il fondovalle. Una preesistente porta (della quale forse permane il settore basamentale) è qui documentata per la prima volta nel 1268. L’area attorno alla porta è interessata ad una più congrua e dignitosa sistemazione urbana.
All’interno del borgo, accanto agli edifici che si svilupparono a schiera lungo i ‘decumani’ ed ai palazzetti si accorpano più unità edilizie ,ne sorgono alcuni a carattere nodale, di una certa qualità architettonica ‘vernacolare’, come la casa posta in angolo tra via San Giuseppe e via di Porta Fredda, nel rione di Ghianderino, che si adatta perfettamente all’andamento planimetrico irregolare del tessuto viario in pendenza, ricorrendo alla soluzione dell’angolo a prua di nave mediante l’inserimento di un tabernacolo (il Tabernacolo di Cantone o Canto della SS. Annunziata). Nel 1723 questo edificio (più basso dell’attuale) era la “casa da lavoratore” del podere di Laterina dei monaci olivetani di San Bartolomeo a Monteoliveto di Firenze.
La trecentesca mole della torre di quella che forse fu la, Porta Fiorentina ancora definisce l’estremità occidentale del borgo e si richiama solo in parte, tipologicamente, alle porte turrite dell’ultimo circuito murario fiorentino (concluso nel 1333), ideate alla fine del Duecento da Arnolfo di Cambio (1245 – ante 1310), forse l’autore anche della pianificazione valdarnese delle ‘Terre Nove’.
Non restano tracce, però, dell’ipotetico fornice originario: il portale attuale, rivolto verso il borgo, è infatti opera assai più tarda dovuta forse ai Busatti.
Il fornice esterno ancora più tardo (1840) è dovuto a un restauro voluto dai Rossi.
Di lato alla torre, lungo il lato meridionale di corso Italia (già corso Vittorio Emanuele e anticamente Borgo Maestro), si trova un grande palazzo, dove già nel tardo Cinquecento dovevano sorgere alcune case appartenenti ai Busatti (messer Giovan Battista, Bartolomeo ed Antonio), l’antica ed importante famiglia laterinese che proprio nella contigua chiesetta di San Biagio aveva almeno dal 1614 un altare di suo patronato, quasi una sorta di cappella privata.
Il palazzo, costruito dai Busatti nel Seicento, presenta una fronte caratterizzata da undici assi di finestre architravate in arenaria, con piattabande a finti conci a punta di diamante e con finestrelle munite di inferriata al pianterreno ed un portale centinato, dalla consueta configurazione a fiamma nell’estradosso dell’arco.
Qui, nel 1733, fu ospitato Carlo, figlio di Filippo V di Spagna. Ancora, in un ambiente terreno modernamente destinato a cucina, esiste un arco ribassato con alcune modanature in stucco ed un cartiglio centrale, ascrivibile al XVIII secolo.
Estintasi la famiglia dei Busatti verso il 1740 con Anna Maria, moglie di Giuliano Rossi, il palazzo passò alla famiglia del marito e la contigua fattoria fu il perno di una delle più importanti tenute della zona. Nel 1776 era di Francesco Rossi e nella prima metà del XIX secolo del cavalier Luigi Rossi, mentre la cosiddetta porta Fiorentina apparteneva allora al cavalier Luigi Tozzi. Nel 1870 le proprietà dei Rossi passarono ai conti Guinigi di Lucca e ad essi dobbiamo, agli inizi del Novecento, la ristrutturazione dell’edificio, con la costruzione della bella scala interna a ferro di cavallo, dotata di un’elegante ringhiera in ghisa liberty. Anche l’ingresso venne decorato secondo gli schemi dell’Art Nouveau, con alcune decorazioni floreali in monocromo e due figure di donna dipinte a tempera di lato alla scala.
La sala madornale al primo piano nobile, con quattro finestre ed un bel solaio a travi policrome, fu decorata con carta da parati di gusto liberty, come anche le altre camere, i cui pavimenti in cotto vennero impreziositi da motivi dipinti. Esternamente, i prospetti furono decorati con elementi pittorici a finto bugnato, losanghe, fasce con grottesche e riquadri, secondo il gusto del tempo, decorazione ancora documentataci in alcune cartoline d’epoca. Un passaggio laterale, che scavalca il vicolo, collega il palazzo alla porta Fiorentina, allora anch’essa di proprietà dei conti lucchesi, detta appunto la Torre Guinigia.
Ad Occidente del fornice della porta, sul terreno già ad uso di vigneto, i Guinigi piantarono un giardino con piante di palma, inquadralo da due pilastri gravati da sculture in terracotta, che si estendeva fino al selvatico, degradante verso valle. Già al tempo dei Rossi, però, esisteva un giardino rustico, che giungeva fino all’oratorio di San Rocco, ricalcante il selvatico di lecci e querce dei Busatti. Nel 1949 la villa-fattoria-palazzo fu alienata ed una parte venne acquistata dai Montigiani; il giardino, donato al Comune di Laterina, fu aperto al pubblico. Recentemente la torre della porta è passata anch’essa al Comune, che sta provvedendo (2001) al suo restauro.