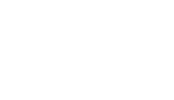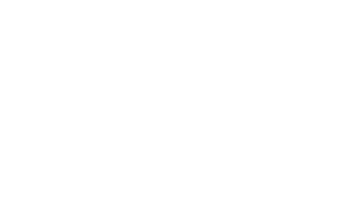Il Crocifisso è in legno di pero dipinto ed è stato restaurato nel 1988 da Daniela Graglia, per conto della Soprintendenza di Arezzo. Al momento del restauro risultava assai danneggiato a causa delle verniciature subite nel corso dei secoli e di alcune mutilazioni. Conservato all’interno della Propositura dei Santi Ippolito e Cassiano, fu commissionato dalla Compagnia del Crocifisso di Laterina. Si tratta di un’opera scultorea di alta qualità, databile al primo-secondo decennio del XVI secolo ed attribuibile alla bottega di Baccio da Montelupo.
L’opera è proprietà della Compagnia del Crocifisso ed è visibile dai fedeli solo durante la festa annuale che si svolge nel mese di settembre. In quest’occasione esso viene tradizionalmente portato in processione dalla Propositura fino alla chiesa di Santa Maria in Valle, dove è custodita la miracolosa immagine della Vergine Maria. La Compagnia del Crocifisso è documentata a partir dal 1420 circa, anno in cui si presume siano stati redatti gli originari statuti. Nel 1785 fu soppressa a seguito delle leggi leopoldine e venne ricostituita nel 1793.
Il Crocifisso è finemente scolpito e modellato: il volto è segnato da linee marcate e precise, i capelli sono formati da una massa compatta, solcata da ciocche leggermente ondulate, il corpo è magro e nodoso ed esprime l’intensa drammaticità della passione del Cristo. Le braccia sono unite al busto tramite due snodi, in modo da adattare la scultura anche nella posizione di Cristo deposto.
Stilisticamente l’opera presenta alcune affinità con i crocifissi di Baccio da Montelupo, soprattutto per l’espressione patetica del volto, ma possiede anche analogie con la bottega di Benedetto da Maiano. Baccio aveva formato, tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, una bottega molto attiva, continuata dal figlio Raffaello. La posizione delle gambe e quella della testa dell’opera laterinese sono ispirate al Crocifisso di Sant’Onofrio ora nell’Educatorio di Foligno. Il volto ricorda invece quello del Crocefisso di Villa La Quiete, che Baccio realizzò nell’ultimo decennio del Quattrocento.
Manola Rosadini